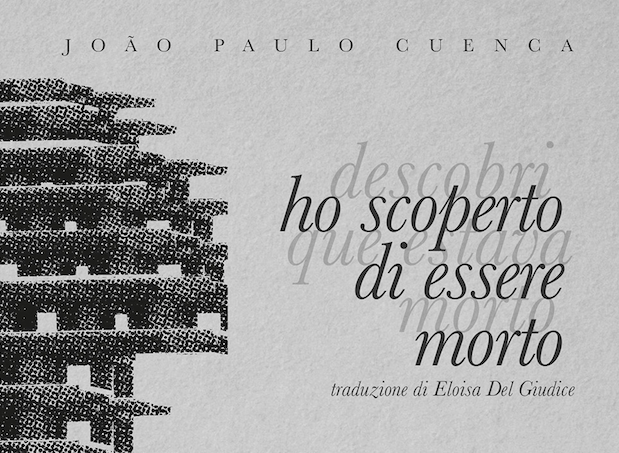[…] una telefonata mi svegliò alle undici di mattina. Era l’ultimo sabato di aprile del 2011.
– Pronto.
– Chi parla?
– Con chi vuole parlare?
– Lei è il signor João Paulo?
– Sì.
– João Paulo Vieira Machado de Cue… – ha un attimo di esitazione.
– Cuenca.
– Esatto. Figlio di Maria Teresa Vieira Machado e Juan José Cuenca?
– Chi parla?
– Chiamo dal 5° Distretto di Polizia. Sono l’ispettore Gomes, abbiamo tirato fuori la sua scheda dopo la denuncia per i disordini al ristorante.
– E?
– E c’è che qui abbiamo un altro verbale, con data 14 luglio 2008, a suo nome.
– Che verbale?
– Lei sa di cosa si tratta? Sì.
– Non ne ho la minima idea.
– Il verbale che ho qui notifica il suo decesso.
– Come?
– La sua dipartita. Qui c’è scritto che lei è morto.
– Io non sono morto.
[…]– Sarebbe bene che lei venisse in commissariato a chiarire questa faccenda.
A un uomo viene comunicata la notizia della propria scomparsa. Di più: questa sua dipartita è cosa ormai datata e possiede tutta la veridicità dell’atto certificato.
Il fatto, anomalo in sé, richiede una spiegazione che sia plausibile e convincente: anche perché chi scompare, oltre a essere il protagonista del romanzo, porta anche il nome del suo autore: José Paolo Cuenca.
Prende l’abbrivio così, da un evento surreale, uno dei più interessanti libri in circolazione degli ultimi tempi, Ho scoperto di essere morto. Già tradotto in otto lingue, portato in Italia da una delle tante scelte felici della lungimirante Miraggi edizioni, questa del giovane romanziere brasiliano è opera di difficile incasellamento: la finta morte, espediente letterario non nuovo ma piegato da Cuenca in modo spiazzante, non porta di fatto all’esito più scontato, la scelta del thriller o del noir, nonostante l’ambientazione sia compresa nel magma di atmosfere dense di una Rio de Janeiro in fermento e preparazione alle Olimpiadi del 2016 – vorace, sensuale, vivissima di voci e corpi giovani in perenne movimento – che ben si presterebbe alle vicende poliziesche e ne occupa invece giusto le prime pagine.
Cuenca decide piuttosto di inserirvi gli elementi del magico sudamericano, mescolandoli poi con la cronaca sociale di un periodo storico ancora gravato da decenni di dittature militari, ma soprattutto con la spiazzante, impietosa, lucidissima e spietata dissezione del milieu frequentato da un Giovane – ma non imberbe, un giovane prossimo ai quaranta – Scrittore, dal destino (quello del personaggio e di chi ne scrive) segnato fin dalla nascita
Era l’ennesimo fine settimana di sole e gli adattatissimi cittadini di Rio de Janeiro camminavano, correvano, andavano in bicicletta sul lastricato, giocavano a calcio e alle sue varianti su sabbia – altinho, futevôlei, bobinho, gol a gol. Gli uomini bevevano acqua di cocco nei chioschi sulla spiaggia di Ipanema, si allenavano sulle attrezzature di metallo, abbronzavano i loro corpi prosperi sul lungomare.
Le donne li ignoravano sfoggiando la loro forma smagliante compressa in vestiti due taglie più piccoli, passi rapidi e sguardo rivolto verso il nulla.
Era su quel palcoscenico sfavillante che quattro decenni prima si erano conosciuti i miei genitori. Un uomo da poco arrivato da Buenos Aires – era venuto all’inizio degli anni Settanta alla ricerca di un’esistenza abbronzata e sabbatica – e una ragazza di famiglia nobile ma spiantata che lavorava in un’agenzia immobiliare. Frequentavano la stessa porzione di spiaggia. Due anni dopo la loro collisione sono nato io, e purtroppo il lato luminoso della giovane coppia si è perso nei meandri della genetica. Se mio padre era speranzoso e atletico e mia madre generosa e amorevole, di tutto questo non è rimasto nulla: da lui ho ereditato la propensione alle attività antieconomiche e la spacconeria. Da lei il genio irritabile e angosciato.
Un debutto in vita privilegiato, da cui eredita, ammette ironicamente, una “vocazione alla tristezza” quanto mai opportuna in chi voglia perseguire la via delle Belle Lettere.
La comunicazione della sua scomparsa gli impone di intraprendere un viaggio in cerca di chiarezza: è solo attraverso la sua” morte” che potrà (ri)costruire la propria identità come uomo e come scrittore. Inizia quindi un suo pellegrinaggio che lo porterà attraverso corridoi di archivi metallici” polverosi antri di enti assortiti di ripetuto squallore, “Tutti quegli archivi, che circondavano tavoli e sedie lasciando poche pareti a vista, contenevano racconti il cui ingrediente comune erano i dissapori tra gli esseri umani della mia città”. Potrebbe essere questa una fucina di altre storie, ma il protagonista non ha tempo, ha l’obbligo di concentrarsi su quella propria, di vicenda. Tanto più cha la ricerca del sé dipartito deve tener presente la vita che va avanti, con gli impegni fittizi del “prima”, ed è qui che lo scrittore brasiliano eccelle in rappresentazione e finezza di dettaglio: agendo come protagonista e guardandosi al contempo da fuori, nel distacco da sé, stila un fitto elenco delle compagnie artistiche o pseudo tali a lui vicine, disseziona un’intera fauna da débauche, trasgressori che non trasgrediscono un bel nulla. Dedica pagine divertenti e dissacranti allo spettacolo di sedicenti scrittori e artisti nullafacenti, copia rifranta di sé stessi nel tentativo abortito di differenziarsi dalla massa – da ogni massa – per una supposta superiorità intellettuale autocertificata. Fanno comunella, riconoscendosi a fiuto tra simili e al contempo vogliono disperatamente elevarsene con convinzione:
Non insistetti riguardo al testo. Avevo l’abitudine di proteggermi da questo tipo di incertezza grazie alla formula magica: questi poveracci non capiscono un cazzo.
[…] Erano designer, produttrici, stiliste e galleriste e avevano un irresistibile attaccamento alle apparenze, oltreché soprannomi monosillabici come Bi e Lu. Davano inizio ai loro incontri complimentandosi calorosamente a vicenda per poi mettere subito silenziosamente a confronto i loro accompagnatori – gli uomini saltavano i commenti limitandosi a controllare scollature e culi altrui in modo sempre meno discreto.
Numerose delle ormai sviluppate femmine che circolavano in questi giri della Zona Sud di Rio de Janeiro avrebbero vissuto con i genitori finché un uomo non le avesse tirate via da casa. Il proposito seminascosto che qualcuno le emancipasse dava loro tratti caratteriali delle donne del secolo scorso, cosa che cercavano di nascondere sotto un femminismo da social e dosi cavalline di moda e sculettamenti sulle note di anonima deep house.
Chiudevano il cerchio tipi come un fotografo brizzolato, un francese abbronzato, un percussionista di samba panciuto, un poeta d’appartamento, un professore universitario con la forfora sulle spalle, il nipote simpatico di un senatore mafioso, un graffitaro concettuale, un saggista di provincia, un direttorino col berretto, un dipendente della televisione, un editorialista di giornale – il solito circo di cretini periferici uniti dalla stessa autostima delirante e inversamente proporzionale ai loro successi.
Formavamo un’intellighenzia barbuta e vagamente artistica. Eravamo tutti molto coinvolti nella cosa artistica, benché nessuno lì fosse in grado di riconoscere cos’era l’arte. Lo scarso talento presente in quella sala sarebbe stato da lì a poco interamente corrotto dalla città – in migliaia sbarcavano ogni anno nella capitale balneare per finire con le speranze macinate e l’anima smerciata a un canale tv o a una casa di produzione audiovisiva di quest’ascendente e provinciale Hollywood che si credeva il centro di qualcosa.
In questa Rio di Stocazzo, borsa di capitale sociale dove tutti erano figli, figliocci o pupilli di qualcuno, il mio sbrilluccichio da scrittore pubblicato era visto con curiosità e una certa condiscendenza.
La voce narrante passa dunque tra l’ “erano” e il “formavamo”, tra l’essere compresi in una cerchia e l’uscirsene sdegnati alla bisogna, tra l’essere autore del romanzo e protagonista stesso in un gioco raffinato, allucinato, talora allucinante.
Conscio di una sottaciuta incapacità di emergere, lo scrittore si stordisce tuffandosi in serate dal finale prevedibile fin dall’inizio, con coppie belle e prospere a immergersi in un programmato, uguale fino alla noia turbinio di eccessi, non prima di essersi passati una mano di giustificativo decoro (Era giunta l’ora di essere engagé, scrive in apertura di capitolo).
Autore e protagonista viaggiano, si cercano, ricordano i tanti scrittori sudamericani scomparsi in giovane età “Álvares de Azevedo, 20 anni; Castro Alves, 24; Augusto dos Anjos, 30; Manuel Antônio de Almeida, 30; Antônio de Alcântara Machado, 33; João do Rio, 39; Lima Barreto, 41; Euclides da Cunha, 43. In questo contesto, quelli che erano arrivati a 56 anni come Clarice Lispector, Lúcio Cardoso e José Lins do Rego erano davvero vecchi”, augurando a sé stesso simile precoce fama: la verità è che quella del personaggio è di fatto una vita vuota, “un’esistenza olografica”, stretta tra pochissima stesura di pagine e grandi promesse, invece, di scrittura, con una propensione al presenzialismo e alle del tutto dimenticabili conferenze che gli procurano più denaro, fama e sesso facile della pubblicazione – sempre rimandata – di un suo libro.
Cuenca irride, porta sotto la lente riti, vezzi e parti buie di un proprio supposto fallimento, pone in essere il dubbio sul mezzo e utilità della scrittura, Attraverso la morte di sé come personaggio, si ricostruisce con ironia in una trama a caselle che si appaiano, si sommano e non sciolgono enigmi, li moltiplicano, anzi, ricordando a tratti il meraviglioso Rayuela, Il gioco del mondo di Cortázar.
La sua è una scrittura funambolica, ricca ma non ridondante, in cui lo sviluppo della trama – pur atteso e costruito con ragionevole tensione in questo romanzo-gioco metaletterario con accenni di Carrère – passa in secondo piano, sorpassato agevolmente dalla godibilità della sua scrittura, pagine tradotte con grande cura per l’edizione italiana da Eloisa Del Giudice.
Anna Vallerugo