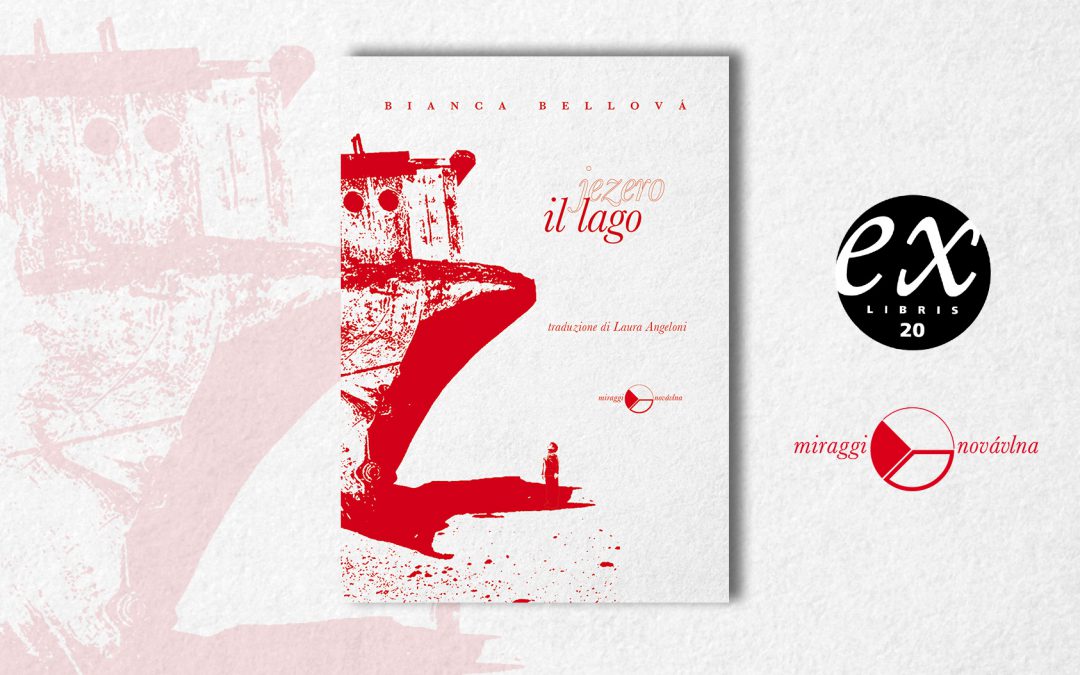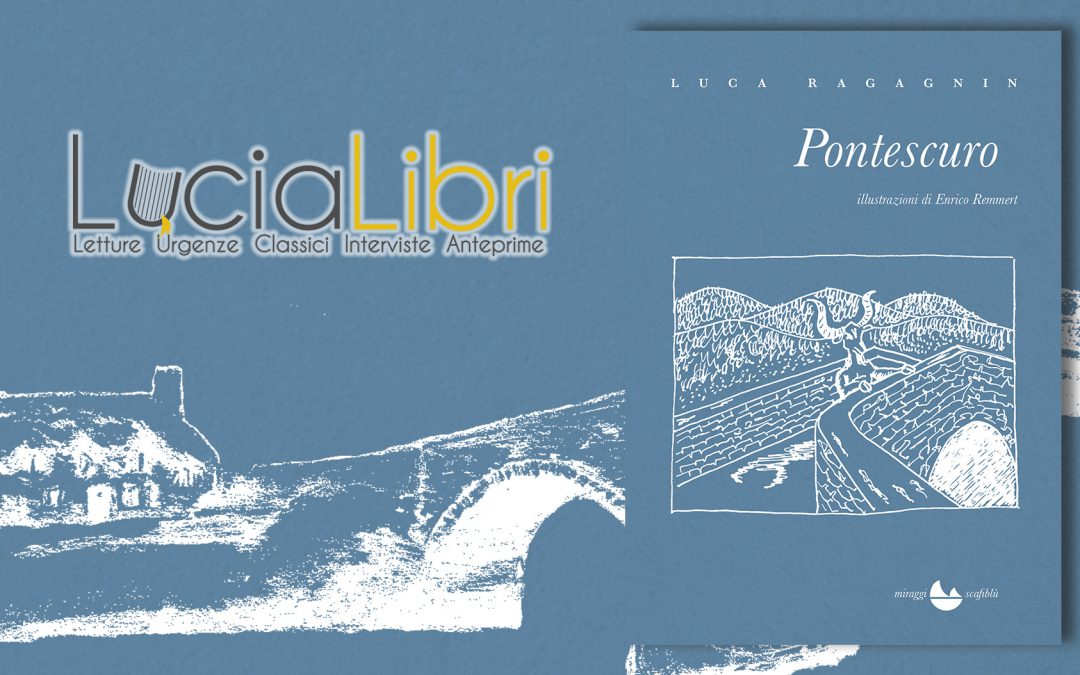Per gli antichi greci le tragedie erano rappresentazioni teatrali con una forte valenza religiosa, morale e sociale. Opere affascinanti e mistiche che hanno lasciato un’impronta nella storia del teatro, del costume, ma anche della letteratura.
Uno di noi, Miraggi edizioni, è l’ultimo lavoro editoriale di Daniele Zito. Siracusano, autore influenzato dalle radici culturali della sua terra, ripropone qui una tragedia in chiave contemporanea, ambientata in Italia.
Quattro amici con l’abitudine della partita di calcetto settimanale, a fine serata, cercano brio e spensieratezza giocando col fuoco.
Chi merita il fuoco?
Sicuramente i “neri”, gli invasori, “che tornassero a casa loro”, questi i pensieri striscianti della combriccola sportiva. Mariti, padri di famiglia, lavoratori, persone dotate di un organo pulsante nel petto, trasformano una serata come tante in un buco nero. Le fiamme appiccate in una baraccopoli prendono il sopravvento e a farne le spese è una bambina. Una piccola disabile che vede fumo, fiamme, ma non può scappare.
Costretta a respirare esalazioni tossiche e crudeltà fluttuanti e gratuite. Vittima sacrificale della stupidità umana. Una piccola anima sospesa nel limbo tra vita e morte, al cospetto della certezza spavalda di quattro miserabili convinti di non essere scoperti.
La verità, prima o poi, viene sempre a galla. E se quasi tutti i protagonisti non riescono a fare i conti con la propria coscienza, non possono sfuggire ai conti con un altro stato d’animo: la paura.
Paura di essere scoperti. Paura di perdere la libertà. Paura di essere arrestati.
Le voci dei protagonisti si susseguono in un vorticoso tifone di stati d’animo, contrastanti tra loro. Crudeltà ed efferatezza di ciò che hanno consapevolmente fatto tornano in superficie, proprio come l’olio sull’acqua. L’eco struggente dell’agnello sacrificale e la sua voce infantile e tenera squarcia il cuore come se fosse una lama.
Uno di noi è un’opera estremamente attuale: un libro che si stratifica nei meandri del male. In un periodo storico nero, in cui il diverso, lo straniero, l’immigrato, diventano capro espiatorio di frustrazioni e intolleranze becere. Stati d’animo che armano il polso di guerrieri “italici”, che, in nome di un falso patriottismo ideologico, scalfiscono la dignità umana, calpestando etica e moralità.
Leggere questo libro è stato difficile (e necessario), perché l’epica di Zito rimbalza dalle pagine e arriva prepotente al lettore, quasi fosse un ceffone in piena faccia. Attraverso le voci disparate e disperate degli “attori in scena” osserviamo la realtà che ci circonda come attraverso un caleidoscopio.
Questa tragedia 2.0 ha il dono dell’immediatezza, brutale e concreta. Difficile abbandonare quest’opera a cuor leggero, perché il sentimento della vergogna emerge tra acque stagnanti. Un germoglio di speranza, che può far fiorire le coscienze. Sperando, come scriveva il buon vecchio Queneau, che dal fango possano nascere fiori blu.
Gabriele Torchietti