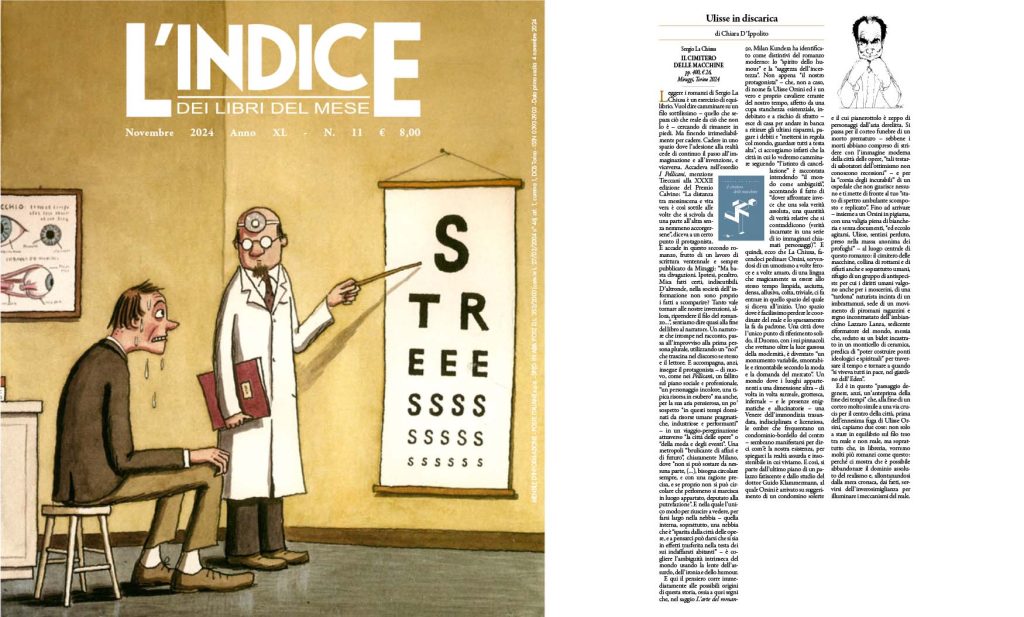di Chiara D’Ippolito
Leggere i romanzi di Sergio La Chiusa è un esercizio di equilibrio. Vuo dire camminare su un filo sottilissimo – quello che separa ciò che reale da ciò che non lo è– cercando di rimanere in piedi, ma finendo irrimediabilmente per cadere. Cadere in uno spazio dove l’adesione alla realtà cede di continuo il passo all’immaginazione e all’invenzione, e viceversa. accadeva nell’esordio IPellicani, menzione Treccani alla XXXii edizione del Premio Calvino: “La distanza tra messinscena e vita vera è così sottile alle volte che si scivola da una parte all’altra senza nemmeno accorgersene”, diceva a un certo punto il protagonista, e accade in questo secondo romanzo, frutto di un lavoro di scrittura ventennale e sempre pubblicato da miraggi: “ma basta divagazioni. ipotesi, peraltro. mica fatti certi, indiscutibili. d’altronde, nella società dell’informazione non sono proprio i fatti a scomparire? tanto vale tornare alle nostre invenzioni, allora, riprendere il filo del romanzo…”, sentiamo dire quasi alla fine del libro al narratore. Un narratore che irrompe nel racconto, passa all’improvviso alla prima persona plurale, utilizzando un “noi” che trascina nel discorso se stesso e il lettore. e accompagna, anzi, insegue il protagonista – di nuovo, come nei Pellicani, un fallito sul piano sociale e professionale, “un personaggio incolore, una tipica risorsa in esubero” ma anche, per la sua aria pensierosa, un po’ sospetto “in questi tempi dominati da risorse umane pragmatiche, industriose e performanti” – in un viaggio-peregrinazione attraverso “la città delle opere” o “della moda e degli eventi”. Una metropoli “brulicante di affari e di futuro”, chiaramente milano, dove “non si può sostare da nessuna parte, (…), bisogna circolare sempre, e con una ragione precisa, e se proprio non si può circolare che perlomeno si marcisca in luogo appartato, deputato alla putrefazione”. e nella quale l’unico modo per riuscire a vedere, per farsi largo nella nebbia – quella interna, soprattutto, una nebbia che è “sparita dalla città delle opere, e a pensarci può darsi che si sia in effetti trasferita nella testa dei sui indaffarati abitanti” – è cogliere l’ambiguità intrinseca del mondo usando la lente dell’assurdo, dell’ironia e dello humour. e qui il pensiero corre immediatamente alle possibili origini di questa storia, ossia a quei segni che, nel saggio L’artedelromanzo, milan Kundera ha identificato come distintivi del romanzo moderno: lo “spirito dello humour” e la “saggezza dell’incertezza”. Non appena “il nostro protagonista” – che, non a caso, di nome fa Ulisse orsini ed è un vero e proprio cavaliere errante del nostro tempo, affetto da una cupa stanchezza esistenziale, indebitato e a rischio di sfratto – esce di casa per andare in banca a ritirare gli ultimi risparmi, pagare i debiti e “mettersi in regola col mondo, guardare tutti a testa alta”, ci accorgiamo infatti che la città in cui lo vedremo camminare seguendo “l’istinto di cancellazione” è raccontata intendendo “il mondo come ambiguità”, accentando il fatto di “dover affrontare invece che una sola verità assoluta, una quantità di verità relative che si contraddicono (verità incarnate in una serie di io immaginari chiamati personaggi)”.
E quindi, ecco che La Chiusa, facendoci pedinare orsini, servendosi di un umorismo a volte feroce e a volte amaro, di una lingua che magicamente sa essere allo stesso tempo limpida, asciutta, densa, allusiva, colta, triviale, ci fa entrare in quello spazio del quale si diceva all’inizio. Uno spazio dove è facilissimo perdere le coordinate del reale e lo spaesamento la fa da padrone. Una città dove l’unico punto di riferimento solido, il duomo, con i sui pinnacoli che svettano oltre la luce gassosa della modernità, è diventato “un monumento variabile, smontabile e rimontabile secondo la moda e la domanda del mercato”. Un mondo dove i luoghi appartenenti a una dimensione altra – di volta in volta surreale, grottesca, infernale – e le presenze enigmatiche e allucinatorie – una Venere dell’immondizia trasandata, indisciplinata e licenziosa, le ombre che frequentano un condominio-bordello del centro – sembrano manifestarsi per dirci com’è la nostra esistenza, per spiegarci la realtà assurda e insostenibile in cui viviamo. e così, si parte dall’ultimo piano di un palazzo fatiscente e dallo studio del dottor Guido Klammermann, al quale orsini è arrivato su suggerimento di un condomino solerte e il cui pianerottolo è zeppo di personaggi dall’aria derelitta. si passa per il corteo funebre di un morto prematuro – sebbene i morti abbiano compreso di stridere con l’immagine moderna della città delle opere, “tali testardi sabotatori dell’ottimismo non conoscono recessioni” – e per la “corsia degli incurabili” di un ospedale che non guarisce nessuno e ti mette di fronte al tuo “stato di spettro ambulante scomposto e replicato”. Fino ad arrivare – insieme a un orsini in pigiama, con una valigia piena di biancheria e senza documenti, “ed eccolo agitarsi, Ulisse, sentirsi perduto, preso nella massa anonima dei profughi” – al luogo centrale di questo romanzo: il cimitero delle macchine, collina di rottami e di rifiuti anche e soprattutto umani, rifugio di un gruppo di antispeciste per cui i diritti umani valgono anche per i moscerini, di una “tardona” naturista incinta di un imbrattamuri, sede di un movimento di piromani ragazzini e regno incontrastato dell’imbianchino Lazzaro Lanza, sedicente riformatore del mondo, messia che, seduto su un bidet incastrato in un monticello di ceramica, predica di “poter costruire ponti ideologici e spirituali” per traversare il tempo e tornare a quando “si viveva tutti in pace, nel giardino dell’eden”.
Ed è in questo “paesaggio degenere, anzi, un’anteprima della fine dei tempi” che, alla fine di un corteo molto simile a una via crucis per il centro della città, prima dell’ennesima fuga di Ulisse orsini, capiamo due cose: non solo a stare in equilibrio sul filo teso tra reale e non reale, ma soprattutto che, in libreria, vorremo molti più romanzi come questo: perché ci mostra che è possibile abbandonare il dominio assoluto del realismo e, allontanandosi dalla mera cronaca, dai fatti, servirsi dell’inverosimiglianza per illuminare i meccanismi del reale.